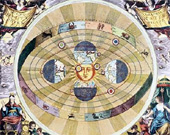|
-
STORIA dell'ASTRONOMIA
- |
|
|
|
Archeoastronomia
| Astronomia antica
| Astronomia medievale |
|
La rivoluzione copernicana
| Astronomia contemporanea |
|
|
|
ARCHEOASTRONOMIA |
|
|
|
Archeoastronomia
| Astronomia antica
| Astronomia medievale |
|
La rivoluzione copernicana
| Astronomia contemporanea |
|
|
|
Archeoastronomia Studio delle attività
connesse alle osservazioni astronomiche effettuate dai popoli antichi, a
partire dai tempi preistorici fino alle culture evolute del Medio Oriente
e dell'America latina. Questo tipo di studi richiede conoscenze di
astronomia, archeologia ed etnografia al fine di interpretare i resti
architettonici e le cronache scritte che manifestino un qualche
significato astronomico. I reperti di interesse astronomico spaziano dalle
pitture rupestri alle grandi strutture megalitiche, come il celebre
complesso di Stonehenge, fino ai sofisticati calendari sviluppati dagli
egizi e dai maya.
|
2 |
|
L’OSSERVAZIONE ASTRONOMICA PRESSO I POPOLI ANTICHI |
Le testimonianze archeologiche raccolte in tutto il mondo dimostrano un
diffuso interesse tra le culture antiche allo studio dei moti del Sole,
della Luna e delle stelle, e di eventi inusuali quali l'apparizione in
cielo di una nova o di una cometa. La regolarità degli eventi celesti
forniva infatti un sicuro sistema di interpretazione degli eventi e di
comprensione del mondo: permetteva di misurare lo scorrere del tempo, di
prevedere gli eventi stagionali (essenziali per le attività agricole), di
intraprendere la navigazione su lunghi percorsi e di sviluppare i
calendari, necessari in qualunque società evoluta.
Le modalità delle osservazioni astronomiche erano diverse a seconda della
cultura dei popoli e della posizione geografica. Nelle regioni tropicali,
i popoli dell'Oceania indicavano le direzioni delle traversate via mare
con un sistema di coordinate basato sulla linea dell'orizzonte, mentre le
culture sviluppatesi nelle regioni temperate utilizzavano come riferimento
l'eclittica. Il livello di complessità di questi antichi sistemi di
orientamento e di osservazione astronomica comincia solo oggi a essere
compreso a fondo.

STONEHENGE, Inghilterra
|
3 |
|
I RISULTATI DELLA RICERCA ARCHEOASTRONOMICA |
I primi studi scientifici sull'orientamento delle piramidi d'Egitto e di
diversi templi ed edifici, in Medio Oriente e in Europa, risalgono al
periodo compreso tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX. Le
ricerche in materia si intensificarono notevolmente al volgere del XIX
secolo, grazie al lavoro di numerosi astronomi, primo fra tutti il
britannico Joseph Norman Lockyer.
Gli studi su Stonehenge e su analoghi siti megalitici indicano chiaramente
che queste strutture venivano orientate in base a precisi piani dettati da
cognizioni astronomiche, quale quella di solstizi e di equinozi. Nel Nuovo
Mondo, le grandi strutture circolari di pietra dette "ruote di medicina"
erano orientate in modo da rilevare il solstizio d'estate. I templi
venivano talvolta utilizzati per segnare le fasi della Luna e il sorgere
di alcune stelle brillanti, come Sirio. Alcune pitture rupestri sembrano
registrare l'esplosione della supernova del 1054, lo spettacolare evento
celeste di cui oggi rimane una suggestiva nebulosa nota come Nebulosa del
Granchio.
Il celebre arazzo di Bayeux, ricamato dai popoli sassoni della Gran
Bretagna dell'XI secolo, all'epoca della conquista normanna, testimonia
l'avvistamento della cometa di Halley del 1066.
|
|
|
|
ASTRONOMIA ANTICA |
|
|
|
Archeoastronomia
| Astronomia antica
| Astronomia medievale |
|
La rivoluzione copernicana
| Astronomia contemporanea |
|
|
|
Astronomia Scienza che ha come oggetto lo
studio di tutti i corpi celesti dell'Universo, tra cui i pianeti, i
satelliti, le comete, gli asteroidi, le stelle, la materia interstellare,
le galassie e gli ammassi di galassie. La moderna astronomia si divide in
branche distinte: l'astrometria, che è lo studio e l'osservazione delle
posizioni e dei moti degli astri; la meccanica celeste, cioè lo studio
matematico dei moti degli astri sulla base della teoria della
gravitazione; l'astrofisica, vale a dire lo studio della composizione
chimica e dello stato fisico degli astri, condotto sulla base dell'analisi
spettrale e delle leggi della fisica; e, infine, la cosmologia, che è lo
studio dell'universo nel suo insieme. Da un altro punto di vista,
l’astronomia si suddivide in branche distinte a seconda del tipo di
radiazione elettromagnetica sfruttata per l’indagine celeste: si parla di
astronomia nei raggi gamma per quel campo di indagine che studia i corpi
celesti attraverso l’analisi della radiazione gamma da essi emessa, e
analogamente si parla di astronomia nei
raggi X, nell’infrarosso e di radioastronomia.
Già in tempi remoti, l'alternarsi del giorno e della notte e le
osservazioni delle posizioni del Sole, della Luna e delle stelle
suscitarono l'interesse dell’uomo, che ben presto iniziò a sfruttare il
moto regolare degli astri per misurare il tempo e per orientarsi sulla
superficie terrestre. L'astronomia si sviluppò a partire dalla necessità
di risolvere piccoli problemi quotidiani quali, ad esempio, quello di
individuare la propria posizione durante i lunghi viaggi, oppure di
stabilire il periodo adatto per la semina e la mietitura delle messi, o
per le celebrazioni religiose. Vedi Archeoastronomia.
I popoli antichi notarono che l'aspetto del cielo mutava con regolarità.
Il Sole, che divide il giorno dalla notte, sorge ogni mattina in una certa
direzione, l'oriente, si muove nel cielo nel corso della giornata e
tramonta nella direzione opposta, l'occidente. Di notte sono visibili
migliaia di stelle che seguono un percorso simile, spostandosi attorno a
un punto fisso, noto come polo celeste.
Anche la diversa durata del dì e della notte venne notata già
nell'antichità. Nel corso delle giornate più lunghe il Sole, visto
dall'emisfero boreale, sorge spostato verso nord rispetto all'est e
raggiunge la sua massima altezza in cielo a mezzogiorno; nel periodo delle
giornate corte, invece, sorge spostato verso sud e rimane più basso
sull'orizzonte. Inoltre, come compreso per la prima volta dagli egizi, nel
corso dell’anno cambia continuamente la sua posizione relativa rispetto
alle stelle.
In seguito fu osservato che il Sole, la Luna e cinque pianeti brillanti si
muovono all'interno di una stretta fascia di cielo detta zodiaco. La Luna
percorre lo zodiaco velocemente, superando il Sole ogni 29,5 giorni circa,
intervallo di tempo a cui venne dato il nome di mese sinodico. Osservando
le stelle, gli antichi tentarono di organizzare una ripartizione del tempo
in giorni, mesi e anni, stabilendo un calendario.
Il Sole e la Luna attraversano lo zodiaco da occidente verso oriente,
mentre i cinque pianeti brillanti (Mercurio, Venere, Marte, Giove e
Saturno) si muovono verso occidente, eccetto in alcuni periodi in cui sono
animati da un moto retrogrado. In queste fasi i pianeti sembrano muoversi
in modo casuale verso oriente, compiendo dei cammini chiusi nel corso del
loro spostamento. Fin dai tempi antichi, la gente ha immaginato che gli
eventi del cielo, e in modo particolare il moto dei pianeti, potessero in
qualche modo influire sulle vicende terrene e questa credenza, che oggi
rappresenta la base dell'astrologia, ha incoraggiato lo studio dei moti
planetari; così, si può dire che in passato, l’interesse astrologico abbia
in parte contribuito al progresso dell'astronomia.
Interessanti mappe delle costellazioni e utili calendari vennero
sviluppati da vari popoli antichi, in particolare dagli egizi, dai maya e
dai cinesi; furono però i babilonesi a raggiungere i risultati più
interessanti. Per perfezionare il loro calendario, essi studiarono i moti
del Sole e della Luna; facevano corrispondere l'inizio di ogni mese con il
primo giorno dopo la Luna nuova, quando la prima falce di Luna crescente
appariva dopo il tramonto. Intorno al 400 a.C. essi notarono che il moto
apparente del Sole e della Luna, da ovest verso est, non avveniva a
velocità costante, ma variabile: i due corpi celesti sembravano accelerare
nella prima metà del moto apparente di rivoluzione, fino al raggiungimento
di un valore massimo, e decelerare nella metà rimanente, fino a
riacquistare la velocità iniziale. Per spiegare questa osservazione essi
formularono i primi modelli matematici sul moto degli astri, mediante i
quali poterono prevedere i tempi della Luna nuova e quindi l'inizio esatto
di ogni mese.
In modo simile i babilonesi calcolarono le posizioni e le velocità dei
pianeti, sia nel moto generale verso est, sia nelle fasi di moto
retrogrado. Gli archeologi hanno ritrovato centinaia di tavolette scritte
con caratteri cuneiformi che mostrano tali calcoli.

SISTEMA
TOLEMAICO
Gli antichi greci portarono importanti contributi teorici all'astronomia.
L'Odissea di Omero contiene riferimenti ad alcune costellazioni
(come il Grande Carro e Orione) e alle Pleiadi, e descrive come le stelle
servissero per la navigazione. Nelle opere di Esiodo si trovano invece
informazioni di carattere astronomico, utili per individuare il momento
migliore per l'aratura, la semina e la mietitura.
Contributi scientifici significativi sono associati ai nomi dei filosofi
Talete di Mileto e Pitagora di Samo, ma di essi non rimangono documenti
scritti. La leggenda secondo la quale Talete predisse correttamente
l'eclisse totale di Sole del 28 maggio 585 a.C. è probabilmente apocrifa.
Intorno al 450 a.C. i greci iniziarono a studiare con successo il moto dei
pianeti. Filolao (vissuto nel V secolo a.C.), sostenitore della teoria
pitagorica, propose che la Terra, il Sole, la Luna e i pianeti si
muovessero attorno a un fuoco centrale nascosto alla vista da una
Antiterra interposta. Secondo la sua teoria, la rivoluzione della Terra
attorno al fuoco ogni 24 ore spiegava il moto giornaliero del Sole e delle
stelle. Intorno al 370 a.C. l'astronomo Eudosso di Cnido spiegò i moti
osservati supponendo che le stelle si trovassero sulla superficie interna
di un'enorme sfera che ruotava attorno alla Terra in 24 ore. Inoltre, per
spiegare il moto del Sole, della Luna e dei pianeti, egli suppose che,
all'interno della sfera delle stelle, vi fossero molte altre sfere
trasparenti che ruotavano con direzioni e velocità diverse.
Il più acuto osservatore del cielo dell'antichità fu probabilmente
l'astronomo greco Aristarco di Samo. Questi era convinto che i moti degli
astri nel cielo fossero spiegabili con l'ipotesi che la Terra ruotasse
attorno a un proprio asse una volta al giorno, orbitando come gli altri
pianeti attorno al Sole. Questa spiegazione venne rifiutata dalla maggior
parte dei filosofi greci i quali, sulla base di una teoria geocentrica
rimasta praticamente inalterata per circa 2000 anni, ritenevano che la
Terra fosse una sfera immobile attorno alla quale orbitavano i corpi
celesti, leggeri e incorporei.
I greci avvalorarono le loro teorie con osservazioni dei corpi celesti
accurate e organizzate. Tavole celesti in cui era riportata la posizione
di oltre 1000 stelle brillanti vennero compilate da Ipparco di Nicea (II
secolo a.C.) e da Tolomeo (II secolo d.C.). Abbandonando le sfere di
Esiodo per un più pratico sistema di cerchi, i due astronomi
rappresentarono il moto generale degli astri sulla fascia dello zodiaco
per mezzo di una serie di cerchi con la Terra vicino al centro comune. Le
periodiche variazioni di velocità del Sole e della Luna e il moto
retrogrado dei pianeti potevano essere spiegati con una scelta appropriata
dei diametri e delle velocità dei cerchi ascritti a ciascun corpo. La
tradizione dell'astronomia greca fu mantenuta viva anche da Ipazia, una
seguace di Platone vissuta ad Alessandria d'Egitto nei primi secoli
dell'era cristiana, che scrisse dei commentari su argomenti di matematica
e di astronomia e viene oggi considerata la prima importante scienziata e
filosofa dell'Occidente.
L'astronomia greca venne trasmessa in
Oriente, ai siriani, agli indiani e agli arabi. Nel IX e nel X secolo gli
astronomi arabi compilarono nuovi cataloghi stellari e svilupparono
precise tavole dei moti planetari, ma benché fossero eccellenti
osservatori, portarono pochi contributi importanti alle teorie
astronomiche. Le traduzioni dall'arabo dell'Almagesto di Tolomeo
stimolarono l'interesse per l'astronomia anche in Europa, dove vennero
compilate tavole del moto dei pianeti e si divulgarono le teorie del
sistema tolemaico. Successivamente il filosofo e matematico tedesco Nicola
Cusano e Leonardo da Vinci misero in dubbio l'assunzione fondamentale
della centralità e immobilità della Terra.
|
|
|
|
ASTRONOMIA MEDIEVALE |
|
|
|
Archeoastronomia
| Astronomia antica
| Astronomia medievale |
|
La rivoluzione copernicana
| Astronomia contemporanea |
|
|
|
ARISTARCO DI SAMO
Aristarco di Samo (310 ca. - 250 ca. a.C.),
filosofo, astronomo e matematico greco. Appare negli scritti di Archimede
quale uno dei primi sostenitori di una teoria eliocentrica – in contrasto
con le dottrine filosofiche e religiose del tempo – che poneva il Sole al
centro dell'universo e la Terra in rotazione intorno a esso. Nell'unica
sua opera giunta fino a noi, Sulle dimensioni e distanze del Sole e
della Luna, l'astronomo definì un metodo per la misura delle distanze
relative del Sole e della Luna dalla Terra, ma la mancanza di strumenti
accurati lo condusse a risultati affetti da sensibili errori.
TOLOMEO
Tolomeo (100 - 178 ca. d.C.), astronomo,
geografo e matematico greco. Da antiche fonti si sa che trascorse la
maggior parte della sua vita presso il tempio serapeo di Canopo, vicino ad
Alessandria d'Egitto, svolgendo le osservazioni che costituirono la base
per lo sviluppo della sua teoria astronomica.

TOLOMEO
La prima e più nota opera di Tolomeo, intitolata originariamente Megalé
mathematiké sýntaxis (Grande sistema matematico), venne tradotta in
arabo col titolo di Al-Majisti. Le traduzioni latine eseguite in
Europa nel corso del Medioevo riportarono il titolo Almagesto, con
il quale essa è giunta fino a noi.
Nell'Almagesto Tolomeo
propose una teoria che, assumendo la Terra immobile e al centro
dell'universo, descrive in termini geometrici e matematici i moti
apparenti e le posizioni dei cinque pianeti allora conosciuti, del Sole e
della Luna inglobati nella sfera delle stelle fisse.
Elaborato sulla base dei dati raccolti dai suoi predecessori, e in
particolare da Ipparco, il sistema tolemaico prevede che i corpi celesti,
quali la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno, ruotino
intorno alla Terra percorrendo orbite perfettamente circolari, dette
deferenti. Per spiegare le irregolarità osservate nei moti dei pianeti e i
cambiamenti di dimensione e di luminosità dei corpi celesti, Tolomeo
sostenne che solo il Sole percorresse il proprio deferente con moto
uniforme, e che la Luna, e in generale gli altri pianeti, si muovessero su
dei cerchi, detti epicicli, i cui centri si muovevano a loro volta sui
relativi deferenti.
Il sistema tolemaico con la complessa teoria degli epicicli poteva
giustificare la maggior parte delle osservazioni astronomiche dell'epoca e
rimase incontrastato fino al XVI secolo, quando l'astronomo polacco
Niccolò Copernico rifiutò il sistema geocentrico, enunciando la
rivoluzionaria teoria eliocentrica.
Benché il suo contributo fondamentale sia da cercare nell'ambito
dell'astronomia, Tolomeo si interessò proficuamente anche di altre
discipline, quali la geografia, la musica e l’ottica. Di notevole
importanza storica è l'opera intitolata Geografia che, con il
sistema di latitudine e longitudine introdotto, influenzò i cartografi per
centinaia di anni, pur non contenendo dati affidabili; nell’opera, Tolomeo
fornì istruzioni su come realizzare una mappa di tutto il mondo conosciuto
all’epoca, trattando il problema matematico della proiezione del globo su
una superficie piana; inoltre, compilò elenchi con nomi di località
corredati delle relative coordinate, precisò confini e diede una
classificazione dei climi.
Per quanto riguarda la musica, Tolomeo espose una teoria dei suoni tipici
della musica greca in un trattato intitolato Armonici. Nell'Ottica
analizzò le proprietà della luce, e in particolare i fenomeni della
rifrazione e della riflessione. Importante è anche il Tetrabiblo,
un trattato in cui tentò di dare fondazione scientifica all'astrologia.
Infine, Tolomeo applicò le sue conoscenze di matematica e astronomia per
la costruzione di astrolabi e meridiane.
|
|
|
|
RIVOLUZIONE COPERNICANA |
|
|
|
Archeoastronomia
| Astronomia antica
| Astronomia medievale |
|
La rivoluzione copernicana
| Astronomia contemporanea |
|
|
|
LA TEORIA DI COPERNICO
La storia dell'astronomia ebbe una svolta decisiva nel XVI secolo, con il
lavoro dell'astronomo polacco Niccolò Copernico. Nella sua grande opera
Sulla rivoluzione dei corpi celesti (1543) egli analizzò criticamente
la teoria tolemaica, mostrando che i moti planetari potevano essere
spiegati assumendo che il Sole, anziché la Terra, occupasse una posizione
centrale.
Il sistema copernicano, o eliocentrico, ricevette scarsa attenzione
nell'ambiente scientifico e filosofico del tempo fino a quando non venne
confermato dalle osservazioni compiute dall'astronomo italiano Galileo
Galilei. Audace sostenitore della teoria copernicana, Galileo costruì un
piccolo telescopio rifrattore per mezzo del quale scoprì quattro lune di
Giove e osservò le fasi di Venere, mostrando che quest'ultimo pianeta
orbita attorno al Sole. Convinto che almeno alcuni corpi celesti non
orbitassero attorno alla Terra, egli iniziò una lunga opera di diffusione
della teoria copernicana (vedi Sistema copernicano), entrando in
acceso contrasto con le autorità ecclesiastiche e con l'ambiente
filosofico.
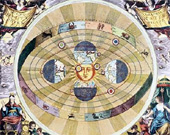
SISTEMA COPERNICANO
Dal punto di vista scientifico, il sistema copernicano era perlopiù una
rielaborazione del sistema di orbite planetarie concepite da Tolomeo. Un
passo decisivo fu compiuto intorno al 1610, quando l'astronomo Giovanni
Keplero, rielaborando i dati raccolti dall'astronomo danese Tycho Brahe,
pubblicò le tre leggi sperimentali sul moto dei pianeti, stabilendo che
questi si muovono attorno al Sole percorrendo orbite ellittiche a velocità
variabile.
L'interpretazione fisica delle leggi di Keplero venne fornita solo in un
secondo tempo con la legge di gravitazione universale elaborata dal fisico
britannico Isaac Newton.
SISTEMA COPERNICANO
Le premesse fondamentali della
teoria copernicana consistono nell'ipotesi secondo cui la Terra ruota per
la durata di una giornata sul proprio asse e, nell'arco dell'anno, attorno
al Sole. Copernico dimostrò inoltre che i pianeti orbitano attorno al Sole
e che la Terra, ruotando, effettua una precessione sul proprio asse
(oscilla come una trottola). L'ipotesi copernicana manteneva numerose
caratteristiche della cosmologia tradizionale, incluse le sfere che
sostenevano i pianeti e le sfere finite più esterne che sostenevano le
stelle fisse. La teoria eliocentrica sul moto dei pianeti aveva tuttavia i
seguenti vantaggi: dava conto dell'apparente moto giornaliero e annuale
del Sole e delle stelle; forniva una spiegazione chiara del moto
retrogrado di Marte, Giove e Saturno, nonché il motivo per il quale
Mercurio e Venere non superavano mai una determinata distanza dal Sole. La
teoria copernicana affermava inoltre che la sfera delle stelle fisse era
immobile.
Un'altra importante caratteristica della teoria copernicana è che essa
consentiva una nuova disposizione dei pianeti in base ai loro periodi di
rivoluzione. Nell'universo di Copernico – diversamente da quanto accadeva
in quello di Tolomeo – maggiore è il raggio dell'orbita di un pianeta,
maggiore è il tempo impiegato dal pianeta per compiere un giro intorno al
Sole. L'idea che la Terra ruotasse intorno al Sole non era tuttavia
accettabile per la maggior parte degli studiosi del XVI secolo; alcune
parti della sua teoria furono adottate, mentre il fulcro fu ignorato o
comunque rifiutato.
Tra il 1543 e il 1600 i
copernicani costituivano una sparuta minoranza. La maggior parte di essi
era estranea all'ambiente accademico e operava presso le corti di
principi, nobili o sovrani; i più famosi, Galileo e l'astronomo tedesco
Giovanni Keplero, riconducevano il loro favore al sistema copernicano a
ragioni diverse. Nel 1588 una posizione intermedia fu sviluppata
dall'astronomo danese Tycho Brahe.
Dopo la condanna della teoria
copernicana, determinata dal primo processo intentato contro Galileo dalla
Chiesa nel 1615-16, alcuni filosofi appartenenti all'ordine dei gesuiti
rimasero segretamente fedeli alle tesi copernicane, mentre altri
adottarono il sistema eliostatico di Brahe. Nel tardo XVII secolo, con
l'avvento del sistema della meccanica celeste proposto da Isaac Newton, i
maggiori pensatori inglesi, francesi, olandesi.
|
|
|
|
ASTRONOMIA CONTEMPORANEA |
|
|
|
Archeoastronomia
| Astronomia antica
| Astronomia medievale |
|
La rivoluzione copernicana
| Astronomia contemporanea |
|
|
|
Dopo l'epoca di Newton l'astronomia si ramificò in varie discipline. Con
la legge della gravitazione, il vecchio problema dei moti planetari venne
studiato alla luce della recente meccanica celeste; il miglioramento dei
telescopi permise l'osservazione dettagliata delle superfici dei pianeti,
la scoperta di molte stelle deboli e la misura delle distanze stellari.
Nel XIX secolo anche i principi della spettroscopia furono applicati allo
studio dei corpi celesti, consentendo la determinazione della loro
composizione chimica e del loro stato di moto. Ne nacque una disciplina
indipendente, comunemente chiamata astrofisica.
Nel corso del XX secolo sono stati costruiti telescopi riflettori via via
più potenti, che hanno permesso di osservare la struttura di corpi celesti
sempre più lontani, quali le galassie e gli ammassi di galassie. Nella
seconda metà del secolo gli sviluppi della fisica hanno condotto alla
realizzazione di nuove classi di strumenti astronomici, adatti per misure
di tipo spettroscopico, alcuni dei quali installati a bordo di satelliti
orbitanti o di sonde interplanetarie o addirittura extrasolari.
Attualmente il campo di studio dell’astronomia non conta più soltanto i
corpi celesti propriamente detti, quali i pianeti, le stelle e le
galassie, ma comprende altre strutture celesti prima sconosciute, quali
l’atmosfera di plasma (gas caldo ionizzato) delle stelle doppie, le
nebulose quali sede di formazione di nuove stelle, e gli addensamenti di
polveri fredde, invisibili ai telescopi ottici. Oggi sono inoltre
all’attenzione degli astronomi oggetti quali i nuclei galattici attivi,
probabilmente occupati da giganteschi buchi neri, e la radiazione cosmica
di fondo originatasi dal Big Bang, che fornisce informazioni sulla storia
dell'universo primordiale.
|
|
|
|
|